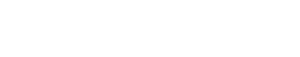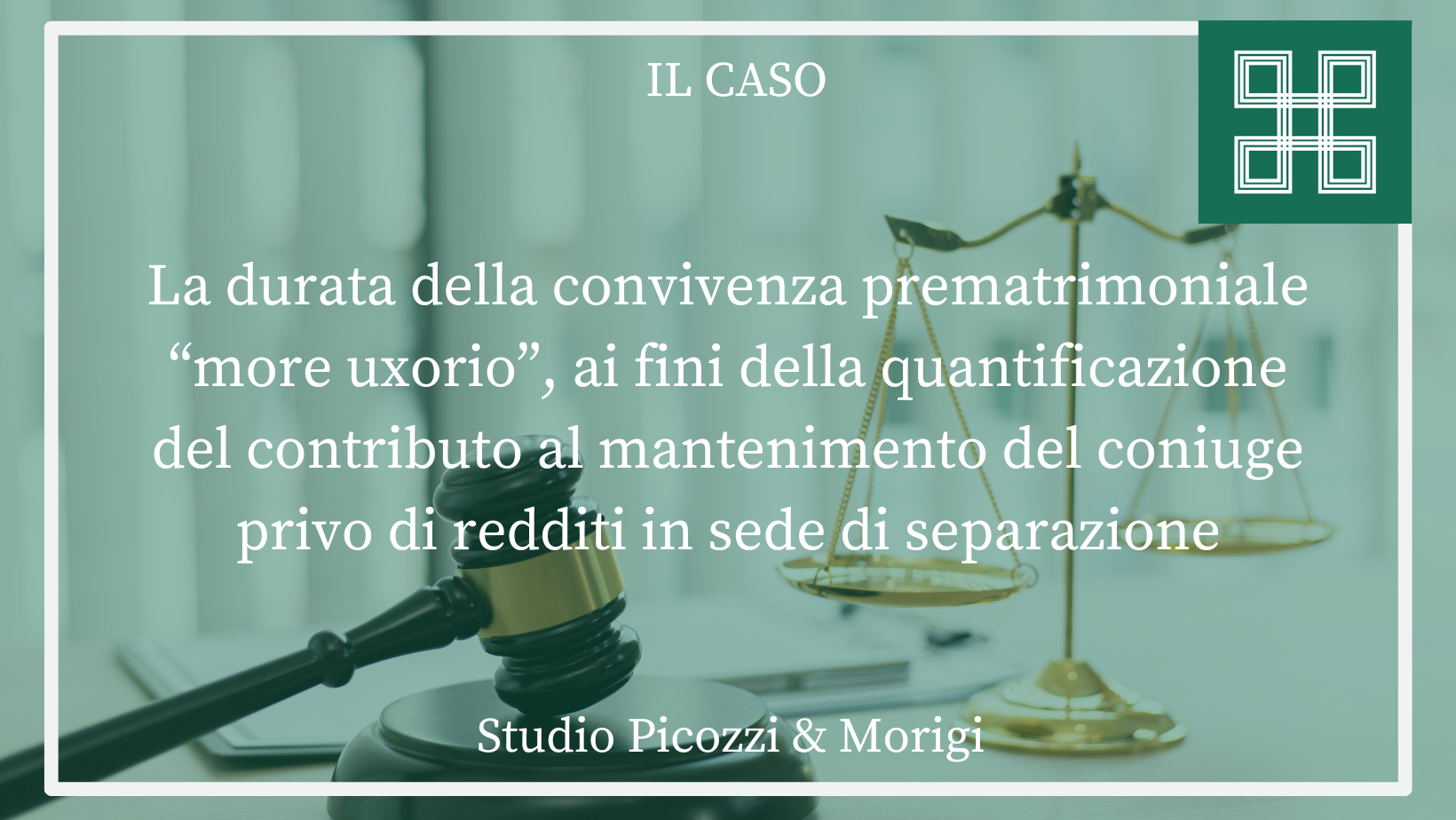
La durata della convivenza prematrimoniale “more uxorio”, ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento del coniuge privo di redditi in sede di separazione
Il caso
In un interessante caso di cui si è occupato il nostro Studio, il coniuge in sede di separazione giudiziale ha contestato il quantum del mantenimento richiesto per sé stesso dall’altro coniuge, asserendo la breve durata del legame matrimoniale (due anni). Il coniuge richiedente il mantenimento ha sostenuto la propria posizione, fondandola sulla durata della convivenza prematrimoniale “more uxorio” (durata tredici anni).
Il quadro normativo
L’art. 156 del codice civile così recita: “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge [38] cui non sia addebitabile la separazione [151], il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri [548,585]. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.
Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli [433] e seguenti [438].
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.”
Preliminarmente, va operata una distinzione tra mantenimento e alimenti, rappresentando il primo una prestazione economica comprensiva di quanto risulti necessario alla conservazione di quello che è stato il tenore di vita in costanza di matrimonio, che può corrispondersi in favore del coniuge che versa in condizioni economiche deteriori rispetto al coniuge con una maggiore capacità reddituale; costituendo, invece, il secondo istituto l’obbligazione patrimoniale, costituzionalmente garantita, che deve essere corrisposta da un coniuge a favore dell’altro coniuge nel momento in cui l’uno sia privo dei mezzi di sostentamento e si trovi in uno stadio di bisogno, oltre ad essere impossibilitato a trovare un lavoro adeguato alle proprie attitudini, nonché alle proprie condizioni fisiche e psichiche.
La durata del matrimonio e il mantenimento
Tra i vari fattori che incidono sul mantenimento e sul quantum dello stesso c’è sicuramente la durata del matrimonio (chiaramente questo elemento è ancora più rilevante nel momento in cui parliamo di divorzio e quindi di assegno divorzile). Tra le recenti sentenze che hanno analizzato questo aspetto vi è la pronuncia del 24 luglio 2024, n. 20507, che chiarisce come la durata del matrimonio breve incida sulla determinazione dell’assegno di mantenimento. In precedenza, infatti, la Corte di cassazione si era pronunciata affermando che la durata del matrimonio non era rilevante per la determinazione dell’assegno di mantenimento, tranne nei casi in cui la durata sia talmente breve da mettere in discussione e in dubbio la costituzione del vincolo coniugale (sentenza Cassazione 31 dicembre 2021, n. 42146).
In questa recente pronuncia di luglio 2024, la Corte di cassazione ha confermato che la durata del matrimonio è considerata principalmente per la quantificazione dell’assegno di mantenimento e non per determinare l’esistenza dello stesso (tuttavia, nel caso esaminato dalla Corte non si parla della convivenza prematrimoniale, assolutamente non analizzata).
La sentenza in parola cita anche una sentenza delle Sezioni Unite del 2022, la n. 32914, che sottolinea come il dovere reciproco di assistenza materiale dopo la separazione debba essere valutato prendendo in considerazione molti parametri, tra cui appunto quello della durata del matrimonio.
Secondo la giurisprudenza consolidata, per stabilire il quantum dell’assegno di mantenimento in caso di separazione devono essere valutati diversi elementi: la capacità di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, la disparità economica rilevante tra i coniugi, la valutazione del contributo di ciascun coniuge al patrimonio familiare e la durata del matrimonio, presa in considerazione ai fini della quantificazione dell’assegno, non per la sua esistenza.
È notorio che la convivenza prematrimoniale, anche detta more uxorio, nel panorama socioculturale italiano sia oramai diffusissima e, a volte, preceda in maniera consistente (in termini di durata) il matrimonio vero e proprio.
Pertanto, questo fenomeno, analizzato con riguardo alla separazione e alla richiesta di mantenimento formulata in detta circostanza da uno dei coniugi, è di notevole interesse da parte della giurisprudenza, già da tempo.
L’evoluzione giurisprudenziale sulla convivenza “more uxorio”
Di fatto, la sentenza della Corte di cassazione n. 17643 del 10 agosto 2007 già affermava che
“in materia di separazione, quanto all’incidenza della convivenza more uxorio di un coniuge sul diritto all’assegno di mantenimento nei confronti dell’altro coniuge, in riferimento alla persistenza delle condizioni per l’attribuzione dello stesso, deve distinguersi tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, sulla base del carattere di stabilità, che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tale da renderlo rilevante giuridicamente”.
La sentenza della Cassazione del 4 maggio 2022, n. 14151, “la convivenza more uxorio, o famiglia di fatto, emerge come una realtà distinta dalla semplice coabitazione con il convivente”, sottolineando così una profonda evoluzione nella percezione di questo fenomeno all’interno della società e del diritto stesso.
Precisa la Corte che la distinzione fondamentale tra la convivenza more uxorio e la mera coabitazione risiede nella natura del legame che viene instaurato con il convivente, perché non si tratta semplicemente di vivere sotto lo stesso tetto, ma di instaurare soprattutto un rapporto affettivo stabile e duraturo, caratterizzato da un impegno reciproco di assistenza morale e materiale tra i conviventi.
Questo comporta che, anche laddove astrattamente mancasse la coabitazione continua, possa ritenersi egualmente esistente una convivenza more uxorio, purché vi sia la volontà dei partner di condividere un progetto di vita comune e di supportarsi reciprocamente, rafforzando così il legame al punto poi, come nel caso di specie, di addivenire alla celebrazione del matrimonio.
Secondo gli ermellini la convivenza è qualcosa di più della mera coabitazione: “la convivenza more uxorio ha da essere intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale, senza che la coabitazione possa assumere il rilievo di un requisito indispensabile all’integrazione del fatto giuridico (v. Cass. 13 aprile 2018, n. 9178; nella stessa prospettiva può leggersi Cass. 21 marzo 2013, n. 7128, che ha accordato il risarcimento del danno da macrolesione del convivente more uxorio pur in assenza di coabitazione: v.; Cass. 7 luglio 2010, n. 16018)”.
Il principio di continuità tra convivenza e matrimonio
Una importante sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione del 18 dicembre 2023, la n. 35385, (chiamata tuttavia ad intervenire in merito alla possibilità di tener conto anche del periodo di convivenza prematrimoniale, cui sia seguito il matrimonio, nella determinazione dell’assegno divorzile) così recita:
“In tema di divorzio, ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno previsto dall’art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase di “fatto” di quella medesima unione e la fase “giuridica” del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e a cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa o professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato successivamente al divorzio.”
Successivamente, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 35969/, si sono espresse sullo stesso argomento ma con riguardo alle unioni civili, sancendo che, alla stregua della convivenza che sfoci nel matrimonio, anche quella che conduce all’unione civile rappresenta inequivocabilmente la volontà delle parti di impegnarsi reciprocamente per il futuro, consolidando quel vincolo che, di fatto, con la L. 76/2016 è stato espressamente riconosciuto dal legislatore come fonte di impegni, di obblighi tra le parti, anche sotto il versante economico.
Convivenza e assegno in sede di separazione
Chiaramente, ora il punto è capire come si possa, in corso di giudizio di separazione, laddove a difesa della propria posizione venga eccepita la brevissima durata del matrimonio ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento, dare rilievo e peso alla lunga durata della convivenza more uxorio.
Sul punto è nuovamente intervenuta recentemente la Cassazione con l’ordinanza del 18 settembre 2024, n. 25055, che così recita: “Ciò che rileva, al fine della quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, e dei figli, è l’accertamento del tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza matrimoniale. Non possono, a tal fine, prendersi in considerazione le spese medie mensili dei due coniugi relative anche agli anni successivi alla separazione. La stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all’assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa. In mancanza dell’elemento oggettivo della stabile coabitazione, l’accertamento dell’effettivo legame di convivenza, allorquando esso costituisca un fattore impeditivo del diritto all’assegno, deve essere compiuto in modo rigoroso, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dal primo comma dell’articolo 2729 c.c.”.
La prova di tale convivenza non si basa su un semplice insieme di documenti o testimonianze dirette, ma piuttosto su una serie di presunzioni e indizi che, nel loro complesso, devono delineare un quadro convincente dell’esistenza di un legame affettivo stabile e duraturo tra i conviventi, come delineato dalla recente giurisprudenza. Questi elementi indiziari possono includere, ma non si limitano a, la coabitazione che, pur non essendo un requisito indispensabile, gioca un ruolo significativo nel fornire un contesto per valutare la natura della relazione tra i conviventi.
Molti aspetti non sono direttamente e facilmente dimostrabili, nonché si possono prestare a interpretazioni differenti da parte di chi le valuta dall’esterno. La valutazione giuridica, quindi, deve affidarsi a un’analisi di elementi fattuali che, presi singolarmente, possono sembrare insufficienti, ma che, valutati nel loro insieme, consentono di inferire l’esistenza di una convivenza more uxorio.
La coabitazione assume, come già detto, un valore indiziario importante in questo contesto, ma è la valutazione complessiva dei vari indizi che permette di stabilire la presenza di una convivenza di fatto. Ciò non vuol dire che la coabitazione non abbia rilievo: esso è anzi assai cospicuo, ma soltanto indiziario, per i fini della prova dell’esistenza di un rapporto di convivenza di fatto, elemento indiziario da valutarsi, in ogni caso, non atomisticamente, come si vedrà subito dopo, ma nel contesto e alle circostanze in cui si inserisce. Viceversa, l’assenza della coabitazione non è di per sé fattore decisivo.
Altri elementi possono includere la durata della relazione, la presenza di figli, la condivisione di spese e investimenti, la testimonianza di amici e familiari, e qualsiasi altra prova che possa indicare un legame affettivo e di assistenza reciproca tra i conviventi. In assenza di una prova diretta, il giudice deve quindi procedere a un’analisi dettagliata e complessiva degli indizi disponibili, seguendo le disposizioni dell’art. 2729 c.c., comma 1, che impone una valutazione attenta e ponderata di tutti gli elementi presuntivi acquisiti al processo, inclusa l’analisi del ruolo di ciascun convivente all’interno della relazione.
Quando l’istruttoria non offra, o non possa offrire, come nel caso in esame, la prova diretta del fatto controverso da provare, ovverosia la sussistenza di convivenza more uxorio come la abbiamo definita sino ad ora e la sua relativa durata, ma offra solo una sequela di indizi o di fatti secondari, dovrà essere il Giudice – secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità – attraverso l’impiego del ragionamento presuntivo, a risalire al fatto da provare e, “nei limiti del rispetto dell’obbligo motivazionale, […] di individuare quali indizi, conosciuti nei modi ammessi dalla legge processuale (fatti pacifici o notori, fatti provati mediante l’assunzione di mezzi di prova o l’espletamento di congegno inferenziale fondato sull’applicazione della pertinente massima di esperienza, per l’accertamento del fatto ignoto, secondo il paradigma dell’art. 2727 c.c.); ma, una volta che abbia compiuto tale operazione, individuando analiticamente gli indizi potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dall’art. 2729 c.c., comma 1, il giudice non può fermarsi ad una simile atomistica valutazione, ma è tenuto, perché la stessa norma lo richiede, a procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati, nonché di eventuali argomenti di prova acquisiti al giudizio”.
In conclusione
Concludendo, provare l’esistenza di una convivenza more uxorio richiede una meticolosa ricostruzione giuridica dei fatti, basata su un insieme di indizi che, nel loro complesso, siano in grado di attestare la reale esistenza di un progetto di vita condiviso e di un legame affettivo profondo e duraturo tra i partner.

Chiara Catalani
Associata